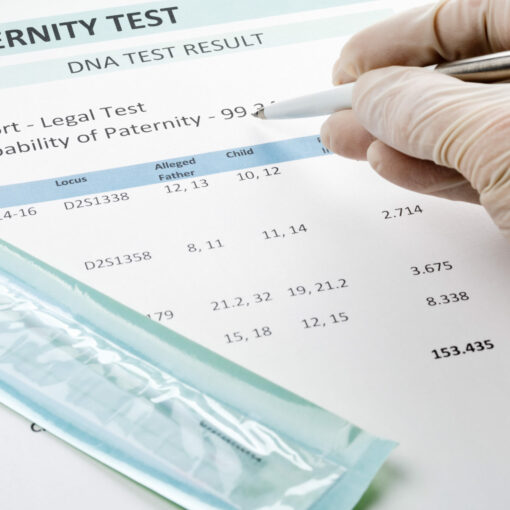La Suprema Corte attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e, in pari misura, perequativa – compensativa, abbandonando definitivamente il parametro del tenore di vita. Dunque, ai fini della determinazione dell’assegno, occorre tenere conto non solo dell’autosufficienza economica del coniuge ma anche del contributo fornito dal partner economicamente più debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro coniuge.
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno sconfessato il precedente indirizzo giurisprudenziale decretando il superamento dello “storico” criterio del tenore di vita dei coniugi. L’art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 prevede la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge “che non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Dal 1990 (Cass. civ., Sez. Unite, sent. nn. 11490/90 e 11492/90), il parametro per valutare l’adeguatezza dei mezzi è stato individuato nel “tenore di vita” analogo a quello goduto in costanza di matrimonio; secondo le Sezioni Unite non occorre, quindi, lo stato di bisogno, ma l’apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche.
A distanza di ventisette anni la Cassazione abbandona tale criterio ancorando la sussistenza del diritto all’assegno al criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica; il revirement è contenuto nella sentenza della Prima sezione Civile n. 11504, depositata il 10 maggio 2017 (relatore dott. A. Lamorgese), con la quale gli Ermellini sostengono che i tempi sono cambiati e occorre “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come «sistemazione definitiva»” perché è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve, quindi, ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”. Pertanto, alla luce di quanto affermato dai Giudici, l’assegno divorzile potrà essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento. Anche in tema di onere della prova si assiste ad un’inversione di rotta poiché grava sull’ex coniuge che chiede l’assegno il compito di provare la mancanza dei mezzi adeguati o dei motivi oggettivi per poterseli procurare dimostrando la circostanza con allegazioni e deduzioni tempestive e pertinenti. I Giudici Supremi hanno, altresì, elencato gli indici dai quali poter desumere l’autosufficienza, i principali sono: “1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri ‘lato sensu’ imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione”.
Alla luce del contrasto giurisprudenziale che si è venuto a creare in materia dopo l’innovativa sentenza “Grilli”, la questione è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite che sono intervenute con la sentenza n. 18287/2018. Secondo i Giudici, per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno occorre individuare un “criterio integrato”, fondato sulla “concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali”. L’assegno, pertanto, non ha più solo funzione assistenziale, ma anche una precisa funzione compensativa e perequativa. Per la Suprema Corte occorre, quindi, tenere conto non solo dell’indipendenza economica del partner ma anche del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione non solo del patrimonio comune ma anche di quello dell’altro coniuge, in considerazione degli anni di durata del matrimonio, delle potenzialità reddituali future e dell’età dell’avente diritto. Il nuovo parametro tende a salvaguardare la posizione del coniuge, tipicamente la moglie, che con lo sposarsi abbia rinunciato alle proprie prospettive di lavoro e di carriera per occuparsi della famiglia, lasciando libero il marito di realizzarsi professionalmente. Tale criterio composito, spiegano i Giudici, “si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”.
Con le sentenze nn. 24932, 24934 e 24935 depositate il 7 ottobre 2019 (il cui giudice relatore è sempre Lamorgese), la Prima sezione della Cassazione ha aggiunto altri tasselli per costruire la nuova identità dell’assegno di divorzio. In particolare, la Corte conferma l’abbandono del criterio del tenore di vita, superando definitivamente l’idea del matrimonio come rendita di posizione che sopravvive anche all’eventualità del divorzio; alla luce di tale cambiamento l’ex coniuge benestante non deve più pagare all’altro “tutto quanto sia per lui sostenibile o sopportabile”, facendo diventare l’assegno quasi un “prelievo forzoso” proporzionale ai redditi. Con le predette pronunce, i Giudici ribadiscono che il criterio fondamentale per attribuire o meno l’assegno continua a essere quello della mancanza di “indipendenza economica” del coniuge che lo richiede, precisando che tale parametro non è stato “sovvertito dalle Sezioni Unite n. 18287, ma solo parzialmente corretto”. Secondo la Cassazione, infatti: a) dopo l’intervento delle Sezioni Unite «risulta confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell’assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa»; b) la funzione compensativa non soccorre tutte le volte in cui «il coniuge richiedente si trova in condizioni di autosufficienza economica. L’esistenza di un obbligo di pagamento dell’assegno implica un perdurante legame di dipendenza economica tra gli ex coniugi che non c’è quando detto obbligo non sussista, cioè quando (e proprio perché) entrambi sono economicamente indipendenti»; c) «il parametro della inadeguatezza dei mezzi va riferito quindi sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all’esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate per avere dato, in base ad accordo con l’altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge».
Recentissimamente, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla funzione compensativa-perequativa dell’assegno (Cass. civ., sez. I, ord. 4 ottobre 2023, n. 27945) chiarendo che, ai fini del suo riconoscimento, il coniuge economicamente più debole deve dimostrare di aver sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e di avere condiviso tale decisione con l’altro coniuge. Non è necessario indagare sulle motivazioni individuali che hanno portato il coniuge a rinunciare alla propria carriera. Secondo i Giudici, “la parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l’assegno, sotto l’aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito”. Né per giustificare la corresponsione dell’assegno, il contributo del coniuge “deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva. […] L’entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell’assegno”.